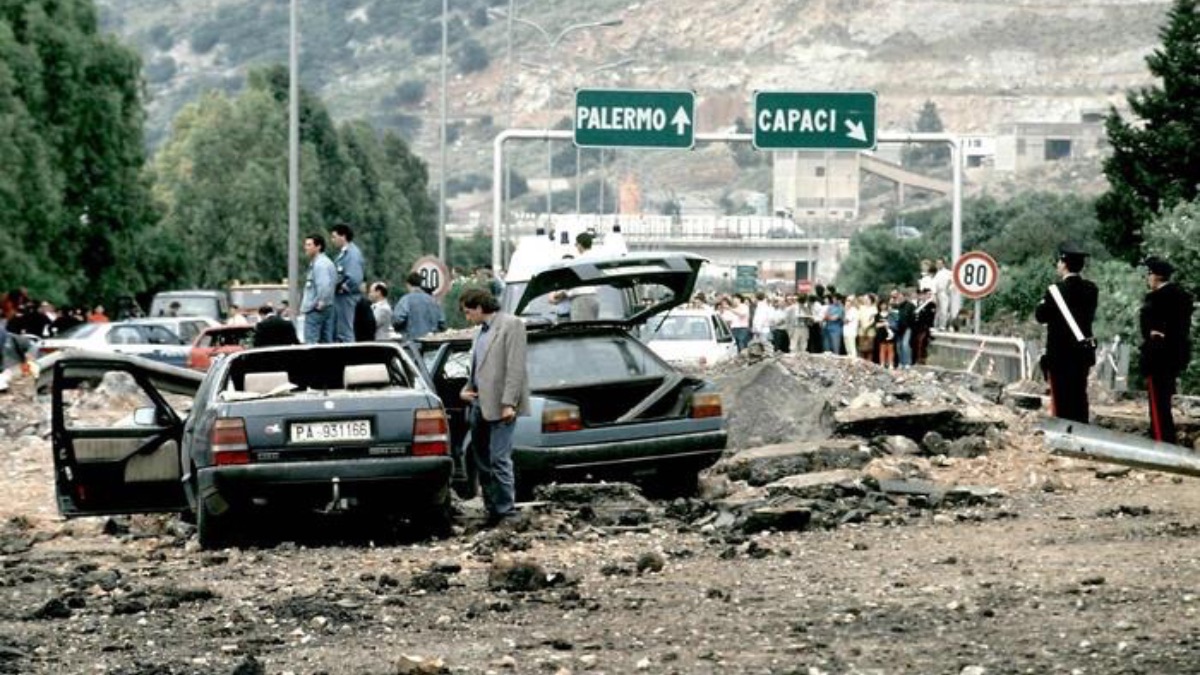di Vittoria Calabrese
La notte tra il 29 e il 30 settembre 1975, Donatella Colasanti, allora diciassettenne, venne ritrovata nel portabagagli di una Fiat 127 bianca, viva ma gravemente ferita, accanto a lei il corpo senza vita della sua amica Maria Rosaria Lopez (19 anni). Roma e l’Italia intera quella notte furono scosse dal crimine che sarebbe passato alla storia come il massacro del Circeo.
Sul luogo del ritrovamento era presente Antonio Monteforte, fotoreporter de Il Tempo, che congelò in uno scatto tutta la violenza esercitata dai ragazzi della Roma bene Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira, che avevano attirato le due giovani con l’inganno in una villa, sottoponendole a violenze psicologiche e sessuali. Chiuse a Villa Moresca, a San Felice del Circeo, Donatella e Rosaria vennero spogliate e seviziate per ore.
Per la prima volta l’abuso sessuale, inteso come delitto contro la persona, irruppe violentemente sul palcoscenico della cronaca nazionale, generando enorme risonanza. La narrazione di quello che venne riconosciuto come un massacro, occorso nel pieno degli Anni di piombo, mostrò un’opinione pubblica impegnata a scovare una ragione alla brutale violenza, confondendo – come ancora oggi accade – vittima e carnefice.
Emerse sin dall’inizio il racconto dell’orrore, ma la narrazione mediatica venne caricata di pregiudizi: le vittime furono descritte come ingenue, colpevoli di essersi fidate, di essersi comportate in modo “disinibito”, perfino di aver “meritato” la violenza per via del loro abbigliamento o comportamento. Un tipo di informazione che non fu affatto marginale, ma che scandì le cronache dell’epoca in presenze in tv, arringhe difensive, articoli ed editoriali che riflettevano la mentalità patriarcale e moralista dominante.
Se dagli ambienti di sinistra veniva sottolineata l’appartenenza a organizzazioni neofasciste dei tre giovani – che avevano precedenti penali per violenze e rapine e frequentavano ambienti dell’estrema destra – dalle pagine della stampa cattolica, come il quotidiano comasco L’ordine, emerse come la misoginia di quegli anni influenzasse l’interpretazione di questo terribile evento. Non vennero condannati i colpevoli ma le vittime, per il loro comportamento discinto e la loro ingenuità, per aver dato fiducia a ragazzi appena conosciuti, prendendo da loro un passaggio verso casa qualche giorno prima.
Le due ragazze vennero ritratte, non solo da questo giornale, come ingenue, finendo per essere descritte come complici e colpevoli delle violenze subite. Addirittura vennero accusate da alcuni di essere arrampicatrici sociali – in quanto appartenenti a una classe meno agiata di quella dei tre pariolini – di aver dovuto pagare il prezzo “necessario” per aver cercato di evadere dal loro status inferiore.
Rosaria, in particolare, venne trasfigurata come Ulisse nell’Inferno dantesco: lei che aveva osato valicare le colonne d’Ercole della sua condizione sociale era stata punita per la sua arroganza e la sua presunzione.
Sempre tra le pagine de L’ordine si legge: “Queste saccenti, petulanti, invadenti, indecenti nel porgere e nel parlare, perché si lamentano se vengono trattate con una volgarità ed una violenza che è tutta animale? Se riducono la vita ad un gioco i rapporti ad uno scherzo senza importanza o irridono alla verginità e alla decenza si servano pure: ma non ci dicano di essere vittime”. Una retorica basata sulla deresponsabilizzazione degli unici veri colpevoli di questo tragico accadimento.
Nel dibattito entrarono a gamba tesa anche i gruppi femministi, rimasti vicini a Donatella durante tutto il processo e nelle testimonianze, fondamentali per un cambio di paradigma nell’affrontare i grandi temi della violenza sessuale e del femminicidio che il massacro chiamò in causa.
Inoltre, questo racconto portato avanti si inseriva in un contesto giuridico-culturale in cui lo stupro non era ancora riconosciuto come reato contro la persona, ma come offesa alla morale pubblica. È solo nel 1996 che la legislazione italiana ha approvato la modifica che rende lo stupro un reato contro la persona.
Il fenomeno della “colpevolizzazione delle vittime” è, purtroppo, ricorrente non solo nella cronaca italiana degli anni Settanta, ma anche oggi. Portiamo ancora il pesante fardello culturale dell’attribuzione delle colpe in parte, se non totalmente, alla vittima.
Tuttora, nei processi, si leggono motivazioni che identificano nella “disinibizione” della vittima una causa attenuante per il carnefice. Come dagli studi sul modo in cui i media rappresentano la violenza di genere emerge che, spesso, l’attenzione si concentra sui dettagli scabrosi della violenza, sul passato o sul profilo personale della vittima, piuttosto che sul contesto strutturale — cioè il patriarcato, la disuguaglianza di potere, la cultura sessista.
E cosi, da un lato, la vittima viene privata della sua dignità e della sua libertà, oltre che della piena riconoscenza del suo diritto a essere creduta e considerata senza condizioni; dall’altro, l’autore del reato può essere in qualche modo sminuito, normalizzato, anziché pienamente responsabile.
Ma la vita di Donatella, dedicata alla testimonianza, ha cambiato l’approccio femminile alla violenza di genere. Parlare e denunciare è diventato possibile anche se il modo in cui gli eventi vengono raccontati resta problematico. Le sue ultime parole pubbliche, prima di morire nel 2005 a causa di un tumore al seno, furono: “Battiamoci per la verità”.
Ecco perché, ancora oggi dopo 50 anni, il ricordo del massacro del Circeo ci spinge a interrogarci sul necessario cambio di regole del racconto pubblico — mediatico, giudiziario, culturale — che smetta di assalire solo la vittima, ma ponga sempre al centro l’autore della violenza, le relazioni di potere, la responsabilità culturale e sociale.